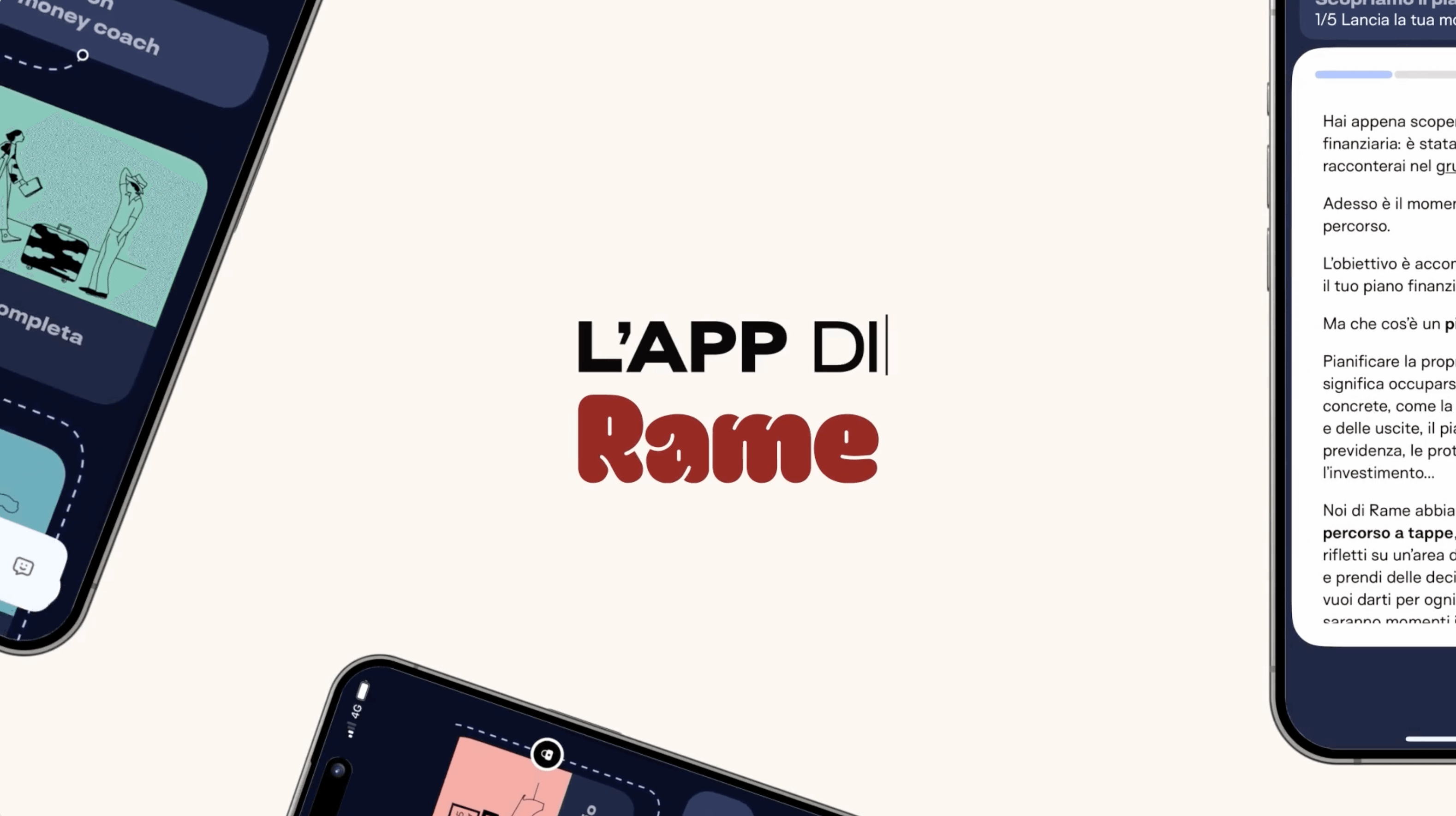Sono figlia di migranti, più povera dei miei genitori
Addes è una Millennial, classe 1985. Una dei tanti trentenni che dopo aver vissuto da soli, viaggiato e studiato all’estero è stata costretta a ripiegare sull’assistenza familiare. Ma per lei è tutto più doloroso. Perché, da figlia di migranti, si va per avere successo e si torna solo per andare in vacanza e portare ricchezza…»
Tempo di lettura: 9 minuti

Sono una ragazza dell’85, una Millennial, la prima generazione più povera di quella dei propri genitori. Sono nella stessa situazione di tanti miei coetanei, ma io sono figlia di migranti e i migranti si spostano in altri Paesi per offrire ai figli le possibilità che non hanno avuto. Ecco perché non riesco ancora ad accettare di avere un potere di acquisto inferiore al loro».
I genitori di Addes Tesfamariam erano arrivati dall’Eritrea a Milano negli anni Settanta. Qui si erano conosciuti e sposati. Avevano trovato lavoro come badanti. E vivevano in un quartiere popolare a Sud di Milano, lungo il Naviglio Pavese, in una tipica casa di ringhiera, di quelle in cui ci si faceva costruire il bagno interno, che ancora mancava. Come gran parte dei migranti, erano dediti al lavoro e al risparmio, anche per poter aiutare la famiglia lasciata nel Paese di origine.
“Il potere del risparmio io l’ho visto con i miei occhi, perché ci ha permesso di spostarci da una casa minuscola, con una stanza da letto unica per tutta la famiglia, in un appartamento grande il doppio con una camera tutta per me.”
La crescita economica della famiglia di Addes è costruita sul risparmio, non sull’emancipazione lavorativa. Ma per lei e suo fratello i genitori vogliono di più: devono studiare e laurearsi, perché «aumentando le competenze si spera che aumentino le opportunità».
Mentre suo fratello interpreta il ruolo del figlio modello, ottenendo il massimo dei voti e avviandosi alla carriera diplomatica, Addes si lascia distrarre dalle sue passioni. Durante gli studi di Scienze Politiche, scopre che le piace truccare, si prende un anno sabbatico per diplomarsi all’Accademia del trucco e inizia a lavorare part-time in un’azienda beauty. Si laurea fuoricorso, quando ormai ha capito che quel lavoro ben pagato, che inizialmente amava tantissimo, non le restituiva la crescita che si aspettava.
«Avevo idealizzato la laurea come il momento di emancipazione lavorativa. Pensavo che mandando il curriculum da laureata nelle aziende giuste, valorizzando le mie competenze e abilità avrei trovato un lavoro o per lo meno uno stage coerente con i miei studi. Sono passati 6 mesi, 8 mesi, un anno: mandavo cv e intanto mantenevo il lavoro nell’azienda beauty che non mi appagava più come prima. Un anno e mezzo dopo, ho deciso che avrei dovuto dare una svolta alla mia vita. Me la sono presa con l’Italia. Mi ero convinta che una laurea non bastasse, dovevo fare un master. Ma non un master qualsiasi, un master all’estero».
Addes lascia il posto fisso nell’azienda beauty, prende i risparmi di 7 anni di lavoro, 13mila euro, e si paga un master.
«Sono una ragazza ambiziosa, la mia prima scelta era Cambridge, la seconda era la Soas, ma poi alla prova del budget ho dovuto ridiscutere i miei criteri. Ho abbandonato l’idea dell’Inghilterra e ho scelto l’Olanda. Ma anche lì, sognavo Amsterdam, Rotterdam, poi ho rifatto il calcolo dei miei risparmi e sono arrivata a Tilburg, una cittadina universitaria nel sud dell’Olanda, vicino Eindhoven, praticamente al confine col Belgio, che aveva dei master che costavano 1900 euro. Ma anche così non è stato sufficiente. Non avevo tenuto in conto tutte le evenienze che possono capitare. E ho dovuto chiedere supporto alla famiglia, che fortunatamente era nella condizione di potermi sostenere».
I tre anni di master sono un sogno. Per la prima volta Addes, trentenne, vive da sola, in un campus universitario, con compagni di corso poco più che ventenni. Per la prima volta vede in cattedra persone della sua età, donne, talvolta migranti. «Più ero in Olanda e più mi arrabbiavo con l’Italia perché vedevo questi ragazzetti di 17 anni che già vivevano da soli grazie a un welfare state che funziona, un governo che vuole che le giovani e i giovani diventino adulti indipendenti».
Finito il master, però, Addes non riesce a coltivare le relazioni personali che fanno la vera qualità della vita. I suoi coetanei trentenni hanno già famiglia, sono in un’altra fase della vita. Inizia ad ammalarsi di nostalgia. E decide di rientrare in Italia.
“Sono tornata con una grande vergogna perché, da figlia di migranti, si va per avere successo e si torna solo per andare in vacanza e portare ricchezza.”
«Dopo 3 anni in Olanda da sola, tornare a casa dei genitori, trovarli più invecchiati, con altri ritmi, non riuscire a introdurmi in un ambiente lavorativo che riconoscesse le nuove competenze acquisite… è stato un periodo duro in cui il mio psicologo mi è stato molto d’aiuto».
Addes sa di vivere una condizione comune a molti, a cui è stato addirittura dato un nome: “generazione boomerang”, coloro che dopo aver vissuto da soli, viaggiato e studiato all’estero sono costretti a ripiegare sull’assistenza all’interno dell’economia familiare. Nel 2014 erano 500mila e oggi sono il 70% dei trentenni a farlo. Ma per lei è tutto più doloroso.
“Sono finita in una spirale di confronti, mi sono ritrovata a farmi domande che mi aiutavano poco e a dire: caspita, i miei genitori sono venuti negli anni 70 a Milano, senza una formazione accademica e però nel giro di 10 anni si sono permessi di prendere un bilocale, sono riusciti a farsi un loro nido, a sposarsi, a fare due figli, con tutte le difficoltà del mondo, facendo i lavori più umili e rispettabili, e io mi ritrovavo dopo la laurea e dopo il master a non riuscire a immaginare neppure una di queste tre cose, né un bilocale per me, né la costruzione di una famiglia con dei figli, né una emancipazione di status di vita.”
Tornata dall’Olanda, Addes fa tre lavori contemporaneamente, che nulla hanno a che fare con i suoi studi: in un centro sportivo per 40 ore alla settimana, nella biglietteria di un teatro e in un pub come cameriera. Per un totale di 1200 euro al mese. «Com’è possibile che in Italia un 40 ore alla settimana venga pagato 15mila euro all’anno? Succede ed è legale e mi suscita una grande rabbia».
In quel periodo Addes riesce finalmente a emanciparsi, andando a vivere da sola. «Ma ancora una volta devo ammettere il mio privilegio. Ci sono riuscita grazie alla bravura nel risparmio della famiglia che facendo una colletta mi ha permesso di iniziare un mutuo per un micro bilocale».
L’arrivo della pandemia sconvolge però l’equilibrio appena trovato. I tre lavori di Addes sono tutti a contatto con il pubblico, e con il lockdown si ritrova a casa, con la cassa integrazione che tardava ad arrivare. «I miei genitori, ormai anziani, venivano a portarmi il pranzo, a farmi la spesa. E io pensavo: “Sono nel pieno della vita, dovrei essere io ad aiutare voi…”. È stato un periodo veramente duro».
C’è una domanda che ho ricacciato in gola più volte durante questa intervista. Credo sia arrivato il momento di tirarla fuori: “Hai mai attribuito la colpa di non riuscire a trovare un lavoro che valorizzasse i tuoi studi, al colore della tua pelle?”
“Il problema non è tanto il colore della pelle, la diversità estetica, quanto l’appartenere a una famiglia migrante che fugge da una guerra a causa della quale non ha potuto emanciparsi con l’istruzione nel Paese di origine. Non mi sono mai sentita diversa fino a quando sono stata in un contesto scolastico. Poi, finita la scuola, mi è crollato il mondo addosso.”
«Tutte le persone che conoscevo avevano trovato un trampolino di lancio tramite le conoscenze che avevano le loro famiglie. E con questo non voglio parlare di raccomandazioni in chiave negativa. Perché io ritengo che siano ottime se ben basate, però io non avevo neanche chi potesse far partire un passaparola. Questa cosa la capisci quando mandi migliaia di curriculum e ti chiedi: “Ma non funziona internet? Perché non mi risponde nessuno?”».
L’essere figlia di migranti appartenenti alla classe operaia ha condizionato anche la capacità di Addes di riuscire a farsi pagare il giusto. «Mi sono ritrovata spesso a lavorare gratuitamente convinta che fosse parte della gavetta. Mi chiedevano una consulenza e io non sapevo quanto farmi pagare, e chi mi stava parlando sapeva che io non sapevo».
Ma la discriminazione più importante sul mondo del lavoro è l’essere donna. «Quando eravamo ragazzi e iniziavamo a cercare lavoretti nei locali, mio fratello faceva più fatica perché la cameriera doveva essere donna. Quando ho lavorato nel mondo del beauty, mi sono sentita accolta per la mia diversità, per la mia nerezza, per l’afro molto grosso che portavo. Però i luoghi di lavoro in cui più ero celebrata per essere donna e originale, col tempo andavano a sparire. Sei donna e carina finché sei giovane. Poi cominciano ad apparire i capelli bianchi. Il ragazzo che cresce diventa sempre più professionale. La ragazza invecchia».
Oggi Addes fa un lavoro solo. «Per la prima volta nella mia vita lavoro dal lunedì al venerdì e ho uno stipendio, 1400 euro al mese, che mi permette di riposare, leggere e investire su me stessa, invece che uscire da un lavoro e andare a farne un altro». Si occupa di progetti culturali per il comune di Milano: un’attività che tiene in conto dei suoi studi, delle competenze acquisite.
“È un lavoro da impiegata, da colletto bianco, quello che ho sempre sognato. Si vola basso quando si hanno poche aspettative.”
Come ha visto fare ai suoi genitori, risparmia il più possibile. «Il doppio di quello che consigliano gli esperti di finanza personale, il 20-30% dello stipendio.
Non posso dire di avere ancora raggiunto l’indipendenza economica. Sono al filo, se domani avessi un’urgenza che mi portasse a spendere più di qualche migliaio di euro dovrei andare a chiedere un finanziamento o riferirmi alla famiglia. Questa è la mia situazione. Però ci sto facendo la pace. È una situazione storica che non posso cambiare.
“Posso solo cambiare il mio approccio e imparare.”