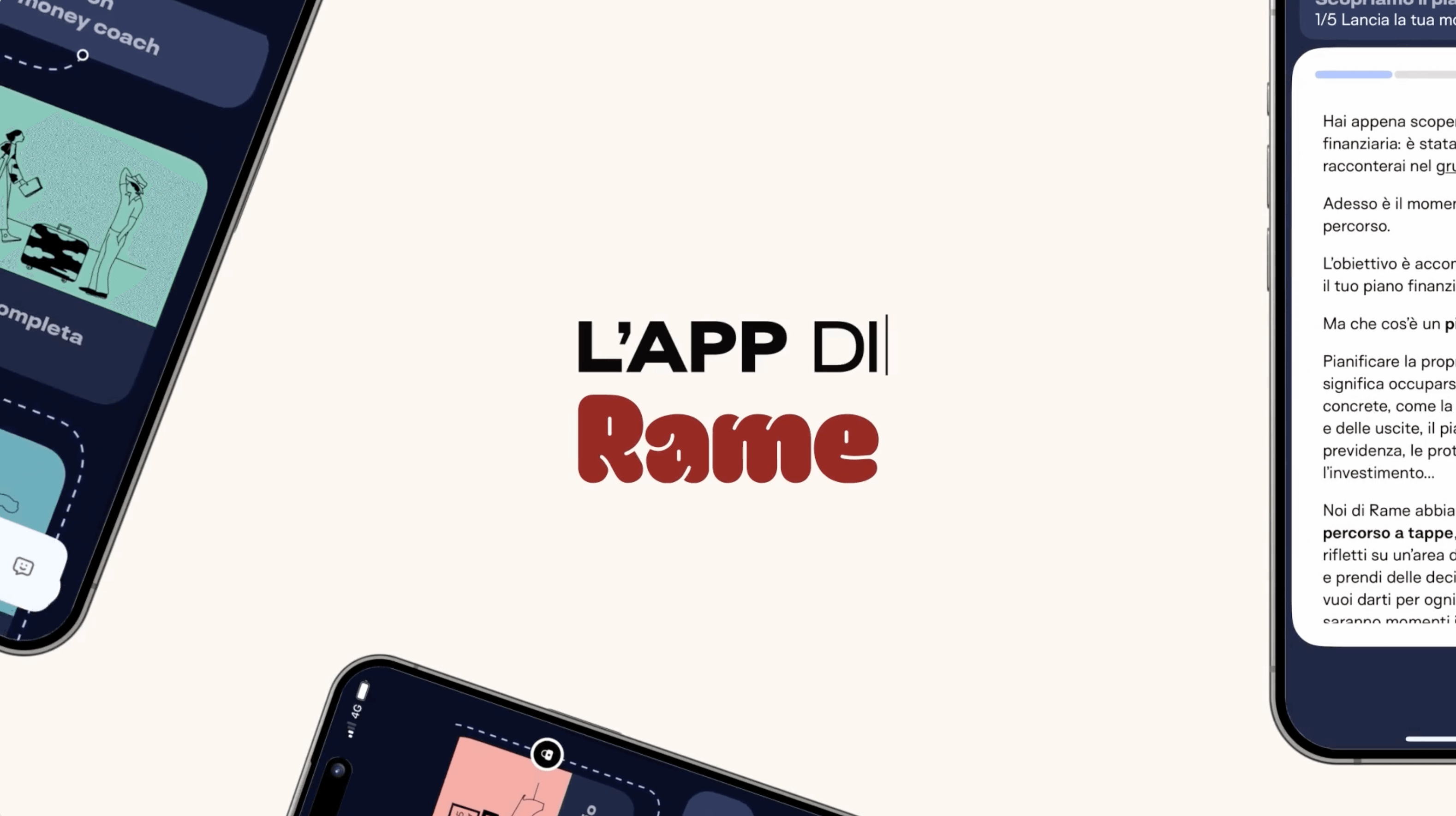Quanto ci pagano è la misura del nostro valore?
È una delle domande che scandiscono Quali soldi fanno la felicità (Feltrinelli), il libro che Annalisa Monfreda, co-founder di Rame, ha scritto a partire dalle oltre 100 storie raccolte nell’omonimo podcast.
Tempo di lettura: 5 minuti

Il modello capitalistico ci dice che ciascuno è pagato per il valore che produce. Ogni eccezione è solo la classica conferma della regola. E, mentre scrivo, sento la voce di Maurizio, ingegnere di Parma con vent’anni di anzianità, che guadagna 1.600 euro al mese, parlarmi del suo amico che fa lo stesso identico lavoro in un’altra azienda, guadagnando tre volte tanto. E confessarmi che questa disparità gli ha fatto perdere ogni spinta emotiva verso il lavoro. Il paradosso è che il modello capitalistico riesce a far convivere il principio per cui ognuno viene pagato per il valore che produce assieme al principio per cui due persone che fanno lo stesso identico lavoro possano essere pagate in modo molto differente. Esattamente come due creme per la pelle, con principi attivi simili, possono costare l’una dieci volte l’altra. Il valore di un prodotto, così come di una persona, ci dice l’economia, è nell’occhio di chi compra ed equivale al prezzo che si è disposti a pagare per avere quel prodotto nella propria vita o quella persona nella propria squadra.
Se è così importante quanto ci pagano, perché sul lavoro non si parla mai di soldi?
Viviamo immersi in una dissonanza cognitiva, riassunta in una frase che America Ferrera pronuncia nel film di Greta Gerwig Barbie, campione d’incassi 2023: “Devi avere soldi, ma non devi chiedere soldi”. Allude a ciò che viene insegnato alle donne, ma è un messaggio subliminale che colpisce trasversalmente l’intera società. Da una parte abbiamo un modello economico, assurto a scienza, che fa equivalere il nostro stipendio o fatturato alla misura del nostro valore; dall’altra abbiamo un preciso diktat culturale che ci dice che no, “non sta bene” parlare di soldi, neanche in una negoziazione di stipendio.
La narrazione del lavoro come passione o vocazione
Se fatichiamo a parlare di soldi sul luogo di lavoro è perché a essere vincente, oggi, è la narrazione secondo la quale dovremmo lavorare non per i soldi, ma per realizzare il nostro senso nel mondo, attraverso il lavoro. Laddove non ci sia una passione o una vocazione da trasformare in lavoro, è il lavoro stesso a premurarsi di fabbricarla. Da anni assistiamo al proliferare di una vera e propria industria della felicità sul lavoro. E se l’idea della felicità sul lavoro fosse progettata per mantenere bassi i nostri salari? Sara Jaffe non ha dubbi che sia così. Ne Il lavoro non ti ama ipotizza che anche il desiderio di felicità e benessere sul lavoro sia stato costruito appositamente per far funzionare un sistema in cui il lavoro della persona media produca più valore di quello che dice il suo stipendio. E questo per la semplice illusione narrativa che quello che non ti arriva sotto forma di stipendio, ti arriva come reputazione, soddisfazione personale, senso di appartenenza, realizzazione di te nel mondo.
La soggettività dei criteri salariali
Se fatichiamo a parlare di soldi sul luogo di lavoro, oggi, è anche perché ci è stato detto che il nostro stipendio equivale al nostro valore. Da quel momento in poi, abbiamo smesso di sentirci una rete di persone che può contrattare insieme condizioni migliori, che può ribellarsi a stipendi troppo bassi e a ritmi di lavoro ingiusti, che può allearsi per far sentire la propria voce. Se quanto ci pagano dipende da criteri soggettivi, allora la contrattazione collettiva dei compensi ha perso ogni significato. La relazione tra noi e il nostro reddito diventa una questione del tutto individuale: dipende dalla nostra capacità di far percepire il nostro valore sul mercato.
Possiamo uscire dalla trappola di credere di valere quanto il nostro stipendio, senza cadere nella trappola opposta, quella di non curarci dello stipendio?
La risposta a questo dilemma forse è riscrivere la teoria del valore. Costruire una cornice oggettiva in una materia del tutto abbandonata alla soggettività. Si tratta di togliere l’opacità che oggi ammanta tutto ciò che è “quanto ci pagano”. Un’opacità che è insita nella stessa struttura salariale “estremamente complessa”, come dice Pietro Ichino, per via delle numerose voci di retribuzione differita o indiretta, cosa che genera “gravi difficoltà nel confronto tra le paghe”, ma che è rafforzata dal codice morale di non parlare di soldi e da una certa idea della privacy che è dietro la delibera del Garante dei dati personali. La quale, nel 2008, come racconta Ichino, «di punto in bianco vietò all’Agenzia delle Entrate di rendere accessibili via Internet i dati delle dichiarazioni dei redditi».
Il potere della trasparenza salariale
Un gesto semplice, dalla portata potenzialmente rivoluzionaria, è dirci quanto guadagniamo. Farlo noi spontaneamente, ma anche lottare affinché venga fatto istituzionalmente, attraverso la trasparenza salariale, un processo che rende chiari i criteri con cui si stabiliscono i salari e che stabilisce fasce salariali per i diversi livelli professionali.
Ogniqualvolta ci sembra che stiamo mettendo i soldi al centro della conversazione, in realtà stiamo togliendo loro potere, stiamo limitando lo spazio che hanno di determinare la nostra autostima. Creando parametri certi e con- divisi, il nostro valore professionale diventa un’entità misurabile, aumentabile con chiare azioni e prende le distanze dal nostro valore più profondo. Non solo: la trasparenza salariale ci libera da quel meccanismo ostentatorio dello stipendio, dalla necessità di conformare il nostro stile di vita all’idea che vogliamo dare agli altri di quanto guadagniamo. E che cos’è la trasparenza salariale, se non un intervento legislativo sul tabù del denaro? Il riconoscimento che lì c’è una falla nel sistema? Le leggi, è bene ripeterlo, sono il modo in cui si dà forma alla società che vogliamo. Questa legge, in particolare, è lo strumento che abbiamo per limitare lo strapotere che i soldi si sono presi, e riportarli alla loro missione iniziale di connetterci e non di dividerci.