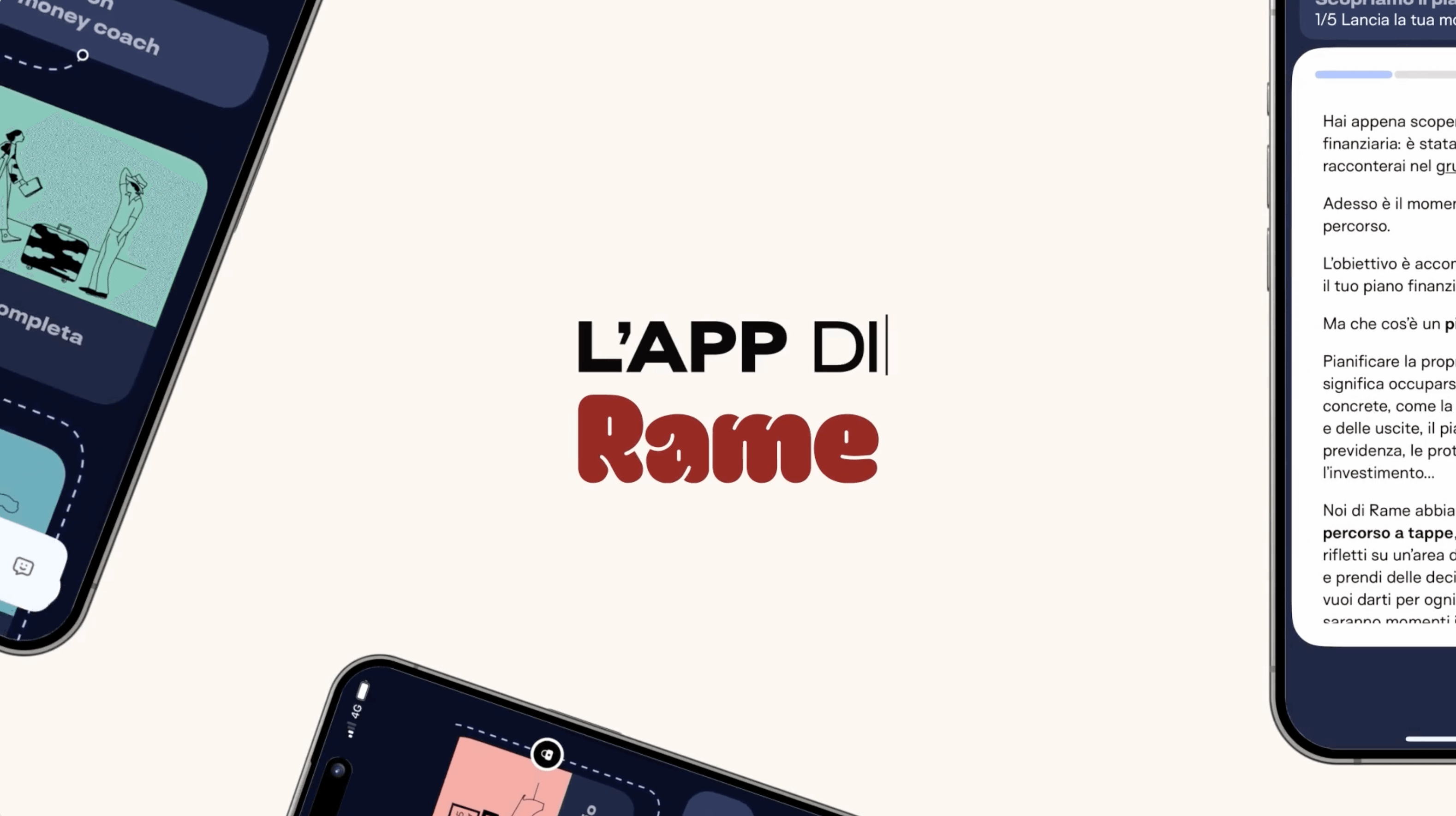La felicità sul lavoro, quanto dipende dalla retribuzione?
La felicità sul lavoro è il tema che tiene banco sui tavoli di Ceo e Hr manager. Molto si è detto su quanto determinanti siano l’ascolto, la soddisfazione per quello che si fa, le buone relazioni, nonché la possibilità di conciliare vita lavorativa e personale. Noi di Rame ci siamo chiesti invece quanto conti uno degli elementi di cui si parla meno, la retribuzione. E se le aziende, concentrate come sono sugli altri aspetti, non stiano sottovalutando l’importanza, per i lavoratori, di vedersi riconoscere il giusto valore?
Tempo di lettura: 5 minuti

di Giorgia Nardelli
Giornalista esperta di diritti dei consumatori e finanza personale.

Fino a tre anni fa Maura lavorava in un’importante agenzia di lobbying. Arrivava agli eventi sul sedile posteriore di auto eleganti, stava imparando a curare le pubbliche relazioni in modo impeccabile e scriveva speech per importanti uomini d’affari. Si divertiva molto, ma a guastare quel contesto dorato c’era il suo stipendio da 1.600 euro al mese. Una volta scesa dalla macchina scura non poteva permettersi né la casa né i viaggi che desiderava, le restavano le grandi responsabilità, il lavoro da finire nei weekend e le nottate in bianco, in compagnia della sua ansia. Finché un giorno ha chiuso la porta, ha fatto un concorso pubblico per un ruolo dirigenziale e lo ha vinto. «Il lavoro che facevo prima mi piaceva molto. Probabilmente se l’atmosfera in ufficio fosse stata diversa, se il capo non fosse stato una iena e i colleghi degli arrivisti senz’anima, ci avrei pensato più a lungo. Ma tre anni lì dentro mi avevano regalato soprattutto frustrazione e la sensazione di non avere prospettive», racconta. Già, il nodo erano le prospettive. E il denaro. Maura non pretendeva valanghe di soldi, ma almeno il necessario per permettersi di condurre una vita all’altezza delle sue aspettative. Se si può trarre una lezione da questa storia, è che fare una professione che ci appassiona non è una garanzia di felicità, e da qui sorge una domanda, quanto mai attuale: quanto la nostra felicità sul lavoro dipende dal nostro guadagno?
Un Paese insoddisfatto
Di felicità e lavoro si parla tantissimo, negli ultimi anni. Dibattiti e tavole rotonde sono affollate da manager delle Risorse umane che spiegano come trattenere i talenti, come rendere felici – e più produttivi – i dipendenti. La situazione di partenza non è facile, lo sappiamo. Secondo Gallup, società specializzata in sondaggi d’opinione, gli italiani sono gli ultimi in Europa per il coinvolgimento sul lavoro, con solo il 4% che dichiara senso di appartenenza alla propria azienda. E questo non è che il primo di una serie di numeri pessimistici, tra cui spicca il 46% di dipendenti che nel 2022 hanno cambiato occupazione, spinto dalla necessità di stare meglio, (qui un report completo). Ci sono poi gli altri numeri, ancor più preoccupanti. Secondo l’Ocse l’Italia è l’unico Paese europeo dove i salari reali sono diminuiti dal 1990 a oggi, perdendo il 7,3% solo nel 2022 rispetto al 2021.
Quanto conta davvero il denaro
Secondo Edoardo Lozza, ordinario di Psicologia dei consumi e dil Marketing e psicologia economica all’Università Cattolica di Milano, il tema è più complesso, e per inquadrarlo bisogna partire da lontano. «Diversi studi scientifici negli ultimi anni hanno indagato il rapporto tra soddisfazione sul lavoro e reddito, e hanno confermato che una relazione tra le due cose esiste: un certo malcontento nei lavoratori deriva anche dal fatto di essere pagati meno di quanto si dovrebbe. Una meta analisi di tutti questi studi ci rivela però che il denaro ha un peso limitato sull’insoddisfazione, in media conta il 15%, sul resto hanno la meglio altri fattori, per esempio la soddisfazione per l’oggetto del proprio lavoro, per il proprio livello di autonomia, per le relazioni sociali che sono all’interno dell’ambiente lavorativo».
Soddisfazione “con tetto”
Il fattore denaro resta determinante, almeno fino a un certo punto, aggiunge Lozza. «Volendo usare una terminologia presa in prestito dal marketing, il reddito è un fattore di igiene, ma non di soddisfazione. È importante che ci sia, ma superato un certo livello non procura un maggiore appagamento, come può succedere per altri fattori. Una volta che mi sono assicurato di ricevere una paga equa e commisurata a quello che penso essere il mio valore, averne una più alta non accresce la mia soddisfazione. È allora che entrano in gioco altri fattori, come ad esempio quello che chiamano benessere aziendale». D’altra parte, una retribuzione che non garantisce uno stile di vita in linea con le nostre aspettative, e con il valore che ci attribuiamo non può che generare frustrazione.
Il peso del confronto
Va detto, spiega l’esperto, che la giusta remunerazione è in un certo senso un valore relativo. «Quando misuriamo ciò che guadagniamo, in realtà lo confrontiamo con quello che prendono gli altri, nello specifico colleghi, oppure persone che hanno lo stesso ruolo in altre aziende. Più che la somma in sé, nella nostra percezione conta quanto guadagniamo in rapporto a chi ci è vicino». La soddisfazione è insomma generata non solo dai soldi in sé, ma dall’avere più degli altri. «Un esperimento condotto nel corso di una serie di colloqui di lavoro, ha mostrato che le stesse fasce di retribuzione venivano valutate dai candidati più o meno positivamente, a seconda di ciò che veniva lasciato intendere loro a proposito degli stipendi aziendali. Più il candidato intuiva che la media dei compensi era alta, più spostava l’asticella in alto, e viceversa».
Viene da sé che tenere nascoste le retribuzioni dei lavoratori aumenta l’equità percepita, e soprattutto abbassa le pretese. «La politica di secrecy rende certamente le persone più “tranquille”, perché è stato provato che i lavoratori sottostimano le differenze di reddito presenti nella propria azienda. Una politica di disclosure scatenerebbe malcontento, ma d’altro canto potrebbe innescare un cambiamento sul versante dei compensi».
La leva della trasparenza
Iniziare a cambiare rotta è l’obiettivo della direttiva europea sulle retribuzioni, che è entrata in vigore e dovrà essere recepita entro il giugno 2026 dagli stati membri. La norma impone alle imprese di informare ogni dipendente sulla paga media di coloro che svolgono un lavoro dello stesso livello. Il punto è quanto gli Stati si adopereranno per rendere la norma di facile applicazione ed efficace, quanto le aziende vorranno applicarla di buon grado. Si discute tanto di felicità sul lavoro, di come attrarre lavoratori capaci instaurando un clima aziendale positivo, promuovendo ascolto, flessibilità e autonomia, ma si parla troppo poco di retribuzioni, un po’ come se l’attenzione si volesse spostare su altri elementi, sorvolando su uno dei problemi chiave. «Senza dubbio avere dipendenti più soddisfatti e un clima aziendale positivo è meno oneroso sul piano puramente economico, che non incidere su altri fattori come le remunerazioni, terreno che costringe a “scontrarsi” con una realtà molto complicata», conferma il professor Lozza. La strada più semplice, però, non è sempre quella più giusta.