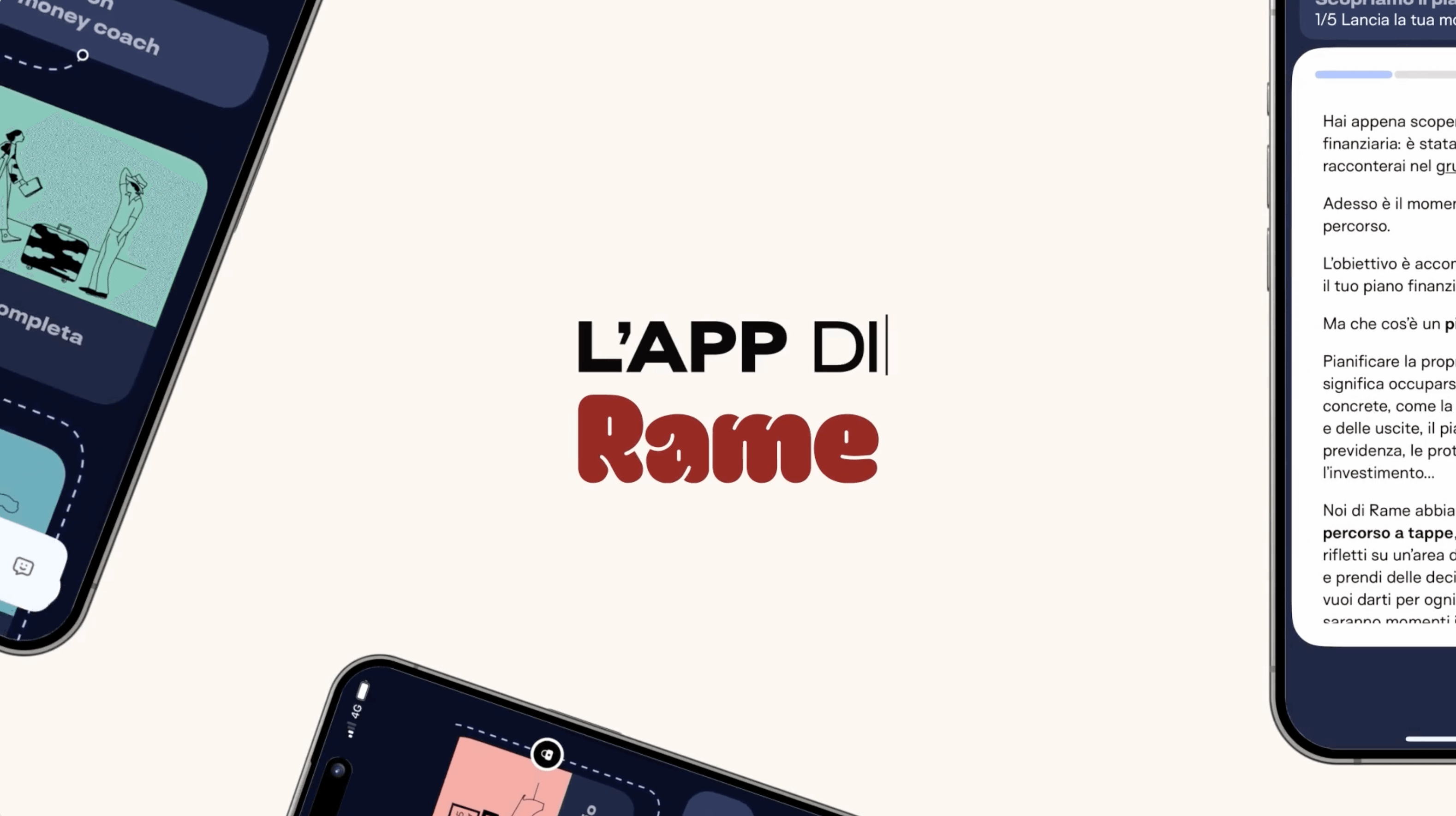Il costo di essere donna
Dal lavoro non pagato in casa a quello sottopagato in ufficio. Dalle spese sostenute per essere magre al guadagno mancato per non essere magre abbastanza. Ogni donna paga innumerevoli costi per il suo genere di appartenenza. Facciamo il conto.
Tempo di lettura: 8 minuti

Il primo tributo all’essere femmine, le donne lo pagano nel mondo del lavoro. È dalla notte dei tempi che il lavoro delle donne viene pagato meno, e poco è cambiato nei secoli.
La disparità salariale
In Italia, secondo i dati Eurostat, il gap medio tra le retribuzioni di uomini e donne è del 5 per cento, molto più basso del 12,7 per cento europeo. Ma la spiegazione di questo apparente virtuosismo sta nel fatto che le donne sono generalmente impiegate in settori a più basso valore aggiunto, dove sono minori le disparità salariali. Che, invece, aumentano notevolmente man mano che si sale nella scala gerarchica, dove le donne, in Italia, quasi scompaiono. Il settore in cui è più alto il divario retributivo è quello dello spettacolo, dove i maschi arrivano a guadagnare il 62,1 per cento in più rispetto alle femmine. Seguono le attività professionali, con uno scarto del 23,9 per cento, la finanza e le assicurazioni, con il 23,7 per cento, e la sanità, con il 21 per cento. Il settore più equo è quello della gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, dove il divario salariale in favore dei maschi è pari ad appena lo 0,7 per cento.
La “qualità” del lavoro e la capacità di spesa
L’aspetto retributivo è un riflesso anche delle diverse condizioni di lavoro in cui si trovano i sessi. Secondo gli ultimi dati Inps le lavoratrici dipendenti lavorano in media 236 giorni l’anno contro i 251 degli uomini; solo il 22 per cento dei dirigenti è donna, tra i quadri la percentuale sale al 32 per cento. Il 31,6 per cento delle donne ha un contratto part-time, per gli uomini la quota è di appena il 7,6 per cento. E se si nasce femmine le percentuali di avere un lavoro temporaneo sono più alte: il 15,2 per cento contro l’11,6 per cento. Questo divario si riflette anche sui consumi. Secondo i dati della Banca d’Italia, le residenti nel nostro Paese spendono in media l’11 per cento in meno rispetto agli uomini (poco meno di 2.700 euro, in valore assoluto), eppure queste spese divorano il 79 per cento del loro reddito individuale contro il 71 per cento degli uomini.
Il prezzo del lavoro di cura
L’economista inglese Kate Raworth ha riportato un’indagine del 2014 su 15.000 madri negli Stati Uniti, secondo la quale “se le donne fossero state retribuite alla paga oraria standard attuale per ognuno dei loro diversi ruoli – che vanno dalla casalinga alla maestra d’asilo, dall’autista di van alla donna delle pulizie – allora le mamme-casalinghe guadagnerebbero circa 120.000 dollari all’anno. Persino le madri che vanno al lavoro ogni giorno guadagnerebbero un extra di 70.000 dollari, oltre al loro salario reale, dato tutto l’accudimento gratuito che forniscono a casa”.
Sappiamo quanto costa alle donne il fatto di svolgere gran parte del lavoro di cura. Il rapporto di Fondazione Cariplo ci dice che al crescere del reddito, si riduce via via la quota di contribuenti di genere femminile. E questo perché le donne lavorano meno, hanno più spesso contratti part-time, a parità di ore lavorate percepiscono stipendi inferiori e tutto ciò si traduce in pensioni mediamente più basse del 36 per cento rispetto a quelle degli uomini. In ogni età della vita, donne e povertà ancora oggi sono sinonimi.
Gli aumenti di stipendio difficilmente ottenuti
“L’idea che le donne non chiedano aumenti come fanno gli uomini è seducente nella sua plausibilità, e collima alla perfezione con gli stereotipi sociali saldamente radicati riguardo ai cosiddetti tratti caratteriali ‘femminili’. Solo che non è vera”. A scrivere è Otegha Uwagba, giornalista e scrittrice, che nel suo libro Dobbiamo parlare di soldi ha sviscerato molto bene questo tema, citando tra l’altro lo studio Do Women Ask?, che dimostra come le donne chiedono aumenti di stipendio con la stessa frequenza degli uomini. Ma è più probabile che tali richieste vengano respinte. Uno studio del 2005 di Harvard rileva che “quando cercano di negoziare compensi più alti, le donne incontrano maggiori resistenze sociali rispetto agli uomini. Vengono penalizzate più duramente anche solo per aver accennato alla possibilità di trattare sullo stipendio, a prescindere dal risultato”. Nel 2016 una ricerca di McKinsey su 34.000 lavoratori afferma che “le donne che chiedono aumenti o promozioni hanno il 30 per cento in più delle probabilità, rispetto ai colleghi maschi, di sentirsi dire che ‘mettono soggezione’ o che sono ‘troppo aggressive’”.
Il trauma finanziario che ogni donna
In Italia il 37 per cento delle donne – più di una su tre – non ha un conto in banca. Non basta però la scarsa educazione finanziaria del nostro Paese a giustificare questi dato impressionante. Da sola, la conoscenza non può restituire potere alle popolazioni o ai gruppi emarginati, come ha scoperto la studiosa Chloe McKenzie, attivista per la giustizia patrimoniale e fondatrice di BlackFem. Dopo anni in questo campo, McKenzie ha realizzato che la conoscenza può influenzare il comportamento, ma non tanto quanto il “trauma finanziario”, ovvero il nostro passato economicamente violento. La storia di come le donne sono state estromesse dall’economia monetaria scorre dentro ognuna di noi. Solo dal 1965 in Francia le donne sposate possono avere denaro a proprio nome e rivolgersi a uno sportello bancario senza essere accompagnate dal coniuge; negli Stati Uniti solo dal 1974 le donne possano avere un proprio conto corrente e una carta di credito, contrarre mutui e finanziamenti senza la firma del marito. Tutto questo rappresenta un trauma collettivo.
Gli altri costi invisibili
Nei paesi occidentali, e in Italia in particolare, le donne più sono magre più guadagnano. Per gli uomini, invece, non ci sono differenze sensibili. “La sanzione per una donna obesa è significativa: le costa circa il 10 per cento del suo reddito,” scrive “The Economist”. Il premio salariale che si ottiene grazie alla magrezza, invece, è quasi equivalente all’istruzione aggiuntiva. E man mano che l’obesità si diffonde tra la popolazione, il premio per la magrezza aumenta. David Lambert, in un documento sulle conseguenze economiche dell’obesità per le donne, afferma che “man mano che le donne invecchiano, subiscono gli effetti di anni di discriminazione salariale cumulativa. I loro salari iniziali sono più bassi e, nel corso della loro carriera lavorativa, queste donne ricevono meno aumenti e promozioni”. Costa essere una donna sovrappeso, se consideriamo il mancato guadagno. Ma costa anche essere in perfetta forma, se pensiamo all’investimento nella magrezza, sotto forma di diete e palestre. Non si tratta solo di essere magre. Ogni donna paga una vera e propria “tassa sulla bellezza”, ossia il prezzo che deve spendere per curarsi secondo gli standard prestabiliti oppure quello che pagherà per non essersi attenuta a esso, sotto forma di stipendio non percepito.
Il costo di invecchiare
La corrispondenza tra bellezza e stipendio è molto ben documentata ed esiste persino una branca dell’economia, la pulcronomia, che studia come la bellezza influenzi le opportunità economiche: “Non appena le donne mostrano dei segni visibili di invecchiamento, sono viste non solo come meno attraenti, ma anche meno competenti,” dice Bonnie Marcus, fondatrice over settanta della Bonnie Marcus Leadership. “Se sembri vecchia, soprattutto come donna, non hai più alcun valore…” Nel libro Dobbiamo parlare di soldi, Otegha Uwagba riporta una ricerca del 2016 in cui i sociologi Wong e Penner osservano che le donne attraenti, ma poco curate, guadagnano quasi il 40 per cento in meno delle colleghe poco attraenti ma molto curate.
La pink tax
Anche curarsi, costa, e tanto. Forse anche perché l’industria sa bene quanto pesi per le donne, nella vita sociale e lavorativa avere un aspetto accettabile. Secondo l’indagine Eurispes “Il rapporto delle donne con il proprio corpo”, nel 2023 tra cosmetici, parrucchiere, depilazione, unghie, trattamenti di vario tipo, il 29,5 per cento delle donne italiane spende tra i 51 ed i 100 euro, il 19,7 per cento tra i 101 ed i 300 euro, il 5 per cento oltre e i 300 euro. A conti fatti, una donna su 4 destina oltre 100 euro al mese alla cura della propria bellezza. E – beffa nella beffa – si tratta di un costo in parte maggiorato. Nel 2015 il Dipartimento per gli affari dei consumatori di New York (Dca) ha condotto uno studio sui prezzi di 800 prodotti cosmetici, in versione sia maschile, sia femminile, scoprendo che i prodotti femminili costavano mediamente il 7 per cento in più rispetto a quelli maschili. Non accade solo lì. Da una ricerca condotta da Idealo nel 2019 su cinque prodotti a campione, è emerso che i deodoranti femminili costano il 51,1 per cento in più rispetto a quelli maschili, i prodotti per il viso il 57,2 per cento in più. Non meraviglia che in Italia già nel 2022, prima dell’ulteriore accelerazione dell’inflazione, una donna su quattro aveva ridotto la quantità di prodotti per cura e igiene personale acquistati.
A proposito di povertà
Il prezzo che pagano per tutto questo, si traduce inevitabilmente in una minore ricchezza personale e in una maggiore fragilità sociale. Ben 6,5 milioni di donne maggiorenni che in Italia sono a rischio povertà ed esclusione sociale. Sono il 25,1 per cento del totale, una delle più alte percentuali registrate nell’Ue a 27, tasso che raggiunge il 28 per cento tra le 18-24enni. A questo si aggiunge un altro dato drammatico. Il numero di donne maggiorenni che in Italia versano in condizioni di povertà assoluta è altrettanto allarmante: 2,3 milioni, il 9 per cento del totale.
Alcuni brani sono tratti dal libro Quali soldi fanno la felicità (Feltrinelli), di Annalisa Monfreda