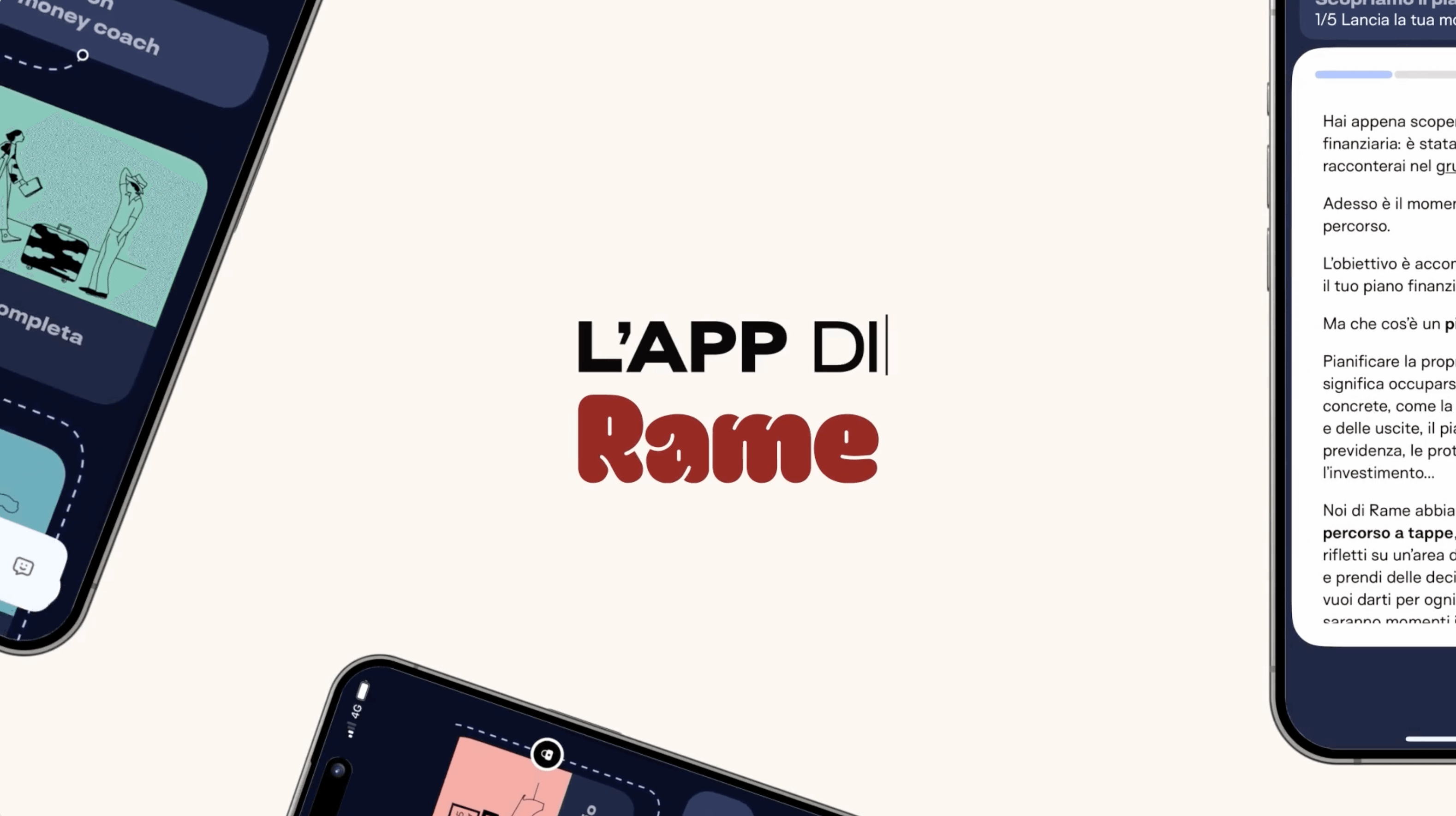Cosa c’è alla base dell’odio verso i ricchi?
L’odio e l’invidia verso i potenti non sono un fenomeno di oggi, ma mai come nella nostra società si avverte un diffuso senso di fastidio e di disprezzo verso chi ha molto, e magari lo ostenta con orgoglio. Mentre le disuguaglianze crescono a vista d’occhio, c’è chi sostiene che sia arrivata l’ora che anche i Paperoni si assumano le loro responsabilità.
Tempo di lettura: 5 minuti
di La redazione

«Voi non volete combattere la povertà, ma la ricchezza», accusava qualche settimana fa la ministra del Turismo Daniela Santanché, rivolta ai partiti dell’Opposizione, mentre, in un misto di orgoglio vittimismo, citava in Parlamento borse di Hermès e origini contadine. Se l’intenzione, in quella che doveva essere una difesa contro una mozione di sfiducia, era spostare l’attenzione generale dal rinvio a giudizio per falso in bilancio e per presunta truffa ai danni dell’Inps, l’obiettivo è stato raggiunto. Quello dell’odio verso i ricchi, quella forma neanche tanto velata di ostilità e verso chi ha tanto, e ancora di più di più verso chi la ricchezza la ostenta senza pudori, è tema antico, che tocca la pancia.
Gli “spregevoli ricchi” nell’immaginario collettivo
«È un sentire universalmente riconosciuto che chiunque possieda una grande fortuna debba in un modo o nell’altro avere qualcosa di spregevole», scrive lo scrittore newyorkese David Roberts, autore nel 2023 del saggio “Gli spregevoli ricchi”, per spiegare la propensione a mal tollerare questa minoranza privilegiata. «Collocare nel “cassetto” dei cattivi chiunque abbia avuto più fortuna e capacità è in un certo senso un modo per lenire il senso di ingiustizia causato dalle disuguaglianze» continua lo scrittore.
In altre parole, l’evidenza che il fato sia stato con noi assai meno generoso che con altri, risulta più digeribile se addolciamo la pillola con l’idea che essere ricchi renda peggiori le persone. A sostegno della tesi c’è una vastissima bibliografia e filmografia che va dal vecchio Ebenezer Scrooge di Dickens, talmente tirchio da rifiutarsi di concedere una piccola elemosina la notte di Natale, alle decine di loschi personaggi che hanno popolato l’immaginario di Wall Street e non solo.
Gioire per le disgrazie altrui
Diretta conseguenza di questo sentimento di irritazione e fastidio è la trasmutazione dell’invidia in “schadenfreude”, dice sempre Roberts, una certa “gioia per la disgrazia altrui”, la stessa che genera un sotterraneo sentimento di rivalsa quando si scopre che Re Mida, resosi conto che persino il cibo che vorrebbe mangiare viene trasformato in oro, muore di fame, solo e disperato. Mica per caso, una delle più seguite telenovele sudamericane degli anni 80 portava il non poco consolatorio titolo “Anche i ricchi piangono”: vedere piangere i fortunati fa sentire tutti un po’ meno piccoli.
Zitelmann e la differenza tra ricchezza meritata e ricchezza immeritata
Ma se quella fortuna e quel denaro sono meritati, sudati, a costo di sacrifici immani, non dovrebbe invece suscitare un senso di ammirazione? Nel 2021, lo storico e sociologo tedesco Rainer Zitelmann ha provato a indagare sulla questione nel saggio “Ricchi! Borghesi! Ancora pochi mesi!”, sottotitolo: “Come e perché condanniamo chi ha i soldi”. Attraverso un sondaggio sottoposto a migliaia di persone, Zitelmann ha analizzato gli atteggiamenti della popolazione nei confronti della ricchezza e dei ricchi in cinque paesi occidentali, tra cui l’Italia. Premesso che le risposte sono state influenzate da fattori come età, genere, reddito e livello d’istruzione, molto eloquente è stato il risultato al quesito che chiedeva agli intervistati di esprimersi su quali gruppi di persone meritassero la propria ricchezza.
Gli italiani si sono mostrati molto comprensivi nei confronti di imprenditori, (secondo il 42% meritano la loro ricchezza), meno per gli ereditieri, (la percentuale si è fermata al 15%), per poi scendere ancora con investitori immobiliari e i banchieri (10% e 8%). Non è questo, però, il dato che più fa riflettere. Nel libro lo studioso ha effettuato una distinzione tra “invidiosi sociali” e “non-invidiosi”, ed è emerso che i cosiddetti invidiosi, erano molto meno propensi a invidiare i vincitori della lotteria. Probabilmente è perché in una società in cui attribuiamo la misura del nostro valore ai soldi, la ricchezza piovuta dal cielo non ci induce a fare paragoni, e a chiederci cosa avremmo potuto fare di più, per somigliare a quelle persone.
La presa di responsabilità
Resta il tema di fondo. Secondo alcuni osservatori, si percepisce nella nostra società un rancore diffuso contro chi ha grandi patrimoni, ossequiati e ammirati certo da molti, ma anche dileggiati, insultati, a volte anche minacciati, nella quasi indifferenza per non dire compiacenza generale. Altrettanto netta è però la sensazione che l’ostilità sia causata dalla sensazione di vivere in una società sempre più diseguale, dove le cose belle sono sempre più riservate a pochi privilegiati, e le barriere all’ascensore sociale si fanno di giorno in giorno più alte. Le tende degli studenti fuori sede, piazzate davanti alle Università all’inizio dello scorso anno accademico sono una raffigurazione emblematica. Anche l’indagine condotta da Demopolis e promossa da Oxfam ci dice che ultimi cinque anni, per 7 italiani su 10 le diseguaglianze economiche (e non solo) sono aumentate.
Se la classe media è inacidita perché ha perso status, reddito, e aspirazioni, e i poveri sono sempre più poveri, allora forse c’è un problema nella nostra società. L’alternativa, quella almeno proposta da movimenti come Tax the Rich, è riconoscere allora che la ricchezza non può essere vissuta e basta, magari limitandosi a sbatterla in faccia a chi non può, ma impone una responsabilità. Ed è quella di contribuire a limare le disuguaglianze.