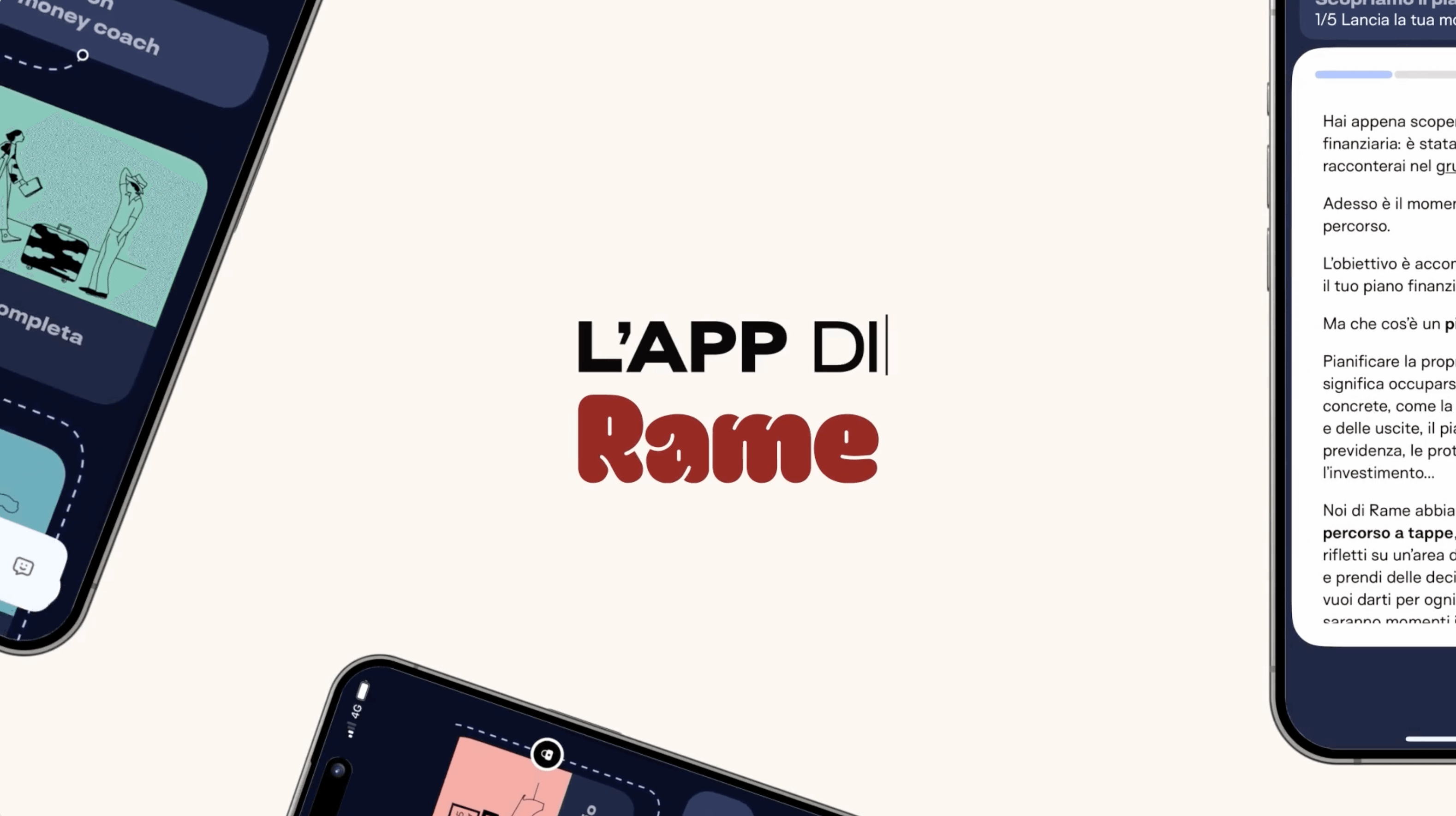Perché dare un valore economico alla natura può proteggerla davvero
L’idea di attribuire un valore economico alla natura è sempre più dibattuta: alcuni lo considerano degradante o troppo complesso, mentre altri temono che una stima monetaria bassa possa giustificare lo sfruttamento delle risorse naturali. Tuttavia, senza una quantificazione chiara, il valore della natura rimane astratto, con il rischio di favorirne il degrado ambientale, come dimostra l’attuale crisi ecologica.
Tempo di lettura: 5 minuti

Hai mai pensato che l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo, il suolo su cui camminiamo possano avere un valore economico? Non in senso simbolico, ma concreto, misurabile, persino monetario. Eppure, questi elementi — fondamentali per la nostra sopravvivenza — sono spesso esclusi da qualunque bilancio, pubblico o aziendale.
È proprio da qui che nasce il concetto di capitale naturale: l’insieme delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici che la natura fornisce gratuitamente, ma che oggi iniziamo a riconoscere come veri e propri asset, alla pari del capitale finanziario o infrastrutturale.
In Italia, un Comitato presso il Ministero dell’Ambiente lavora per stimare il valore della natura, con il contributo anche della Banca d’Italia. Il Comitato redige tutti gli anni un corposo report, con valutazioni quantitative e, ove possibile, monetarie, del valore della Natura italiana.
La domanda, però, rimane: la Natura ha un valore economico? La risposta è generalmente affermativa, ma la questione si complica quando si cerca di quantificarlo. Alcuni ritengono che attribuire un valore alla Natura sia degradante, poiché è “inestimabile”, mentre altri pensano che sia troppo complesso. D’altra parte, c’è chi è contrario alla valutazione della natura perché teme che un valore monetario ridotto ne faciliti lo sfruttamento. In realtà, studi mostrano che, se opportunamente stimato, spesso il valore monetario anche solo di alcune componenti ambientali è enormemente superiore al valore di mercato attribuito alle attività che le danneggerebbero. Tuttavia, senza una stima, il valore della Natura resta astratto e la crisi ambientale ne è la prova.
L’equiparazione del capitale naturale al capitale economico
Secondo il Rapporto ISPRA sul consumo di suolo 2024, ogni giorno in Italia vengono consumati 20 ettari di suolo per l’espansione edilizia. Ciò implica che aree naturali, come campi, boschi e prati, vengano trasformate in infrastrutture artificiali che non supportano alcun processo vitale, come se il capitale naturale fosse preso in prestito. Anzi, preso e basta.
Se il suolo venisse trattato come un bene economico, le imprese che utilizzano terreni per costruire dovrebbero considerare il valore del suolo non solo dal punto di vista agricolo, ma anche in relazione alle molteplici funzioni vitali che il suolo stesso svolge, come la regolazione del clima, la purificazione dell’acqua e la conservazione della biodiversità. Perciò, se l’occupazione di suolo fosse gestita come un vero prestito, l’impresa di costruzioni dovrebbe quantificare il valore di queste funzioni vitali perse e pianificare la sua restituzione integrale nel tempo. Ad esempio, potrebbe prevedere l’installazione di un tetto verde, che, seppur non ripristinando completamente le funzioni naturali del suolo, cerca di imitare alcune delle sue caratteristiche ecologiche. Inoltre, al termine della vita dell’edificio, l’impresa dovrebbe restituire il terreno, ripristinandone la fertilità e la biodiversità.
Ma perché questo non succede?
Chi si occupa di natura e sostenibilità, sia come professionista che come volontario, si scontra spesso con il tema della mancanza di risorse economiche per finanziare le attività che sarebbero necessarie. I progetti di transizione ecologica aziendale, o di ripristino di ecosistemi danneggiati, vengono spesso percepiti come “troppo costosi”. Si finisce così per ripiegare su attività estemporanee più facilmente comunicabili ma dagli impatti molto minori, di cui la piantumazione di alberi è sicuramente il più noto e gettonato.
I professionisti della natura, quindi, sono spinti dal mercato ad una gara a ribasso, alla ricerca del progetto più economico da impacchettare nel marketing più accattivante, investendo decisamente di più sul processo di marketing stesso che sulle attività concrete. Da qui al greenwashing il passo è realmente breve, e può coinvolgere anche aziende in buona fede, i cui responsabili credono sinceramente di aderire ad iniziative meritevoli. Si alimenta così la percezione che non ci sia un mercato per iniziative più solide e valide, e tale percezione diventa facilmente realtà.
C’è una via di uscita?
Il quadro è complesso, ma se c’è, di sicuro la direzione da prendere si chiama Biodiversity Finance, l’insieme di pratiche tese a raccogliere ed investire capitali finanziari con lo scopo di mantenere o ripristinare la biodiversità. Esempi di strumenti utili sono l’iniziativa BIOFIN delle Nazioni Unite, rivolta ai governi nazionali, che ha prodotto già nel 2018 un Workbook (ora aggiornato al 2024) con una precisa metodologia e una carrellata di strumenti pratici. Soggetti come la Capitals Coalition si rivolgono invece più specificamente al mondo corporate e offrono strumenti integrati che considerano anche la dimensione sociale, il capitale umano, oltre a quello naturale.
Più in generale oggi si parla di economia “Nature positive”, o rigenerativa, ossia capace di generare, oltre al profitto economico, anche valore ecologico concreto e misurabile. A livello internazionale, si moltiplicano gli strumenti che supportano analisi dettagliate e specifiche sulle relazioni fra attività economiche umane e capitale naturale, consentendo di integrare questi aspetti nel decision making strategico del business.
I generici messaggi di allarme e urgenza legati alla crisi climatica ed ambientale attuale rischiano di creare ansia e cadere nel vuoto, ma gestire con competenza e senza improvvisazioni il mondo del capitale naturale con i più moderni strumenti a disposizione consente di essere proattivi, razionali e strategici, ottimizzando i propri sforzi, e ottenendo persino un reale vantaggio competitivo.